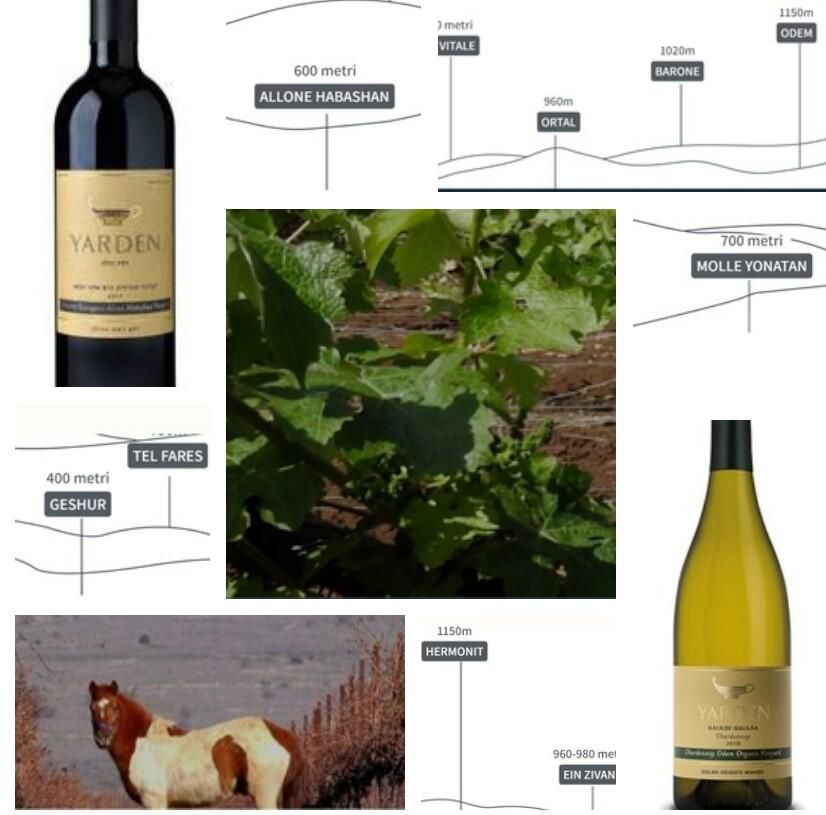La prima parte dell’articolo a questo link https://www.susannabasile.it/valle-daosta-vini-e-vitigni-prima-parte/
Sembra che in queste terre già la tribù dei Salassi, preistorici abitatori della Valle, praticassero la coltura della vite. Sono del 515 d.C. le prime testimonianze della viticoltura, ma è durante il Medioevo che i vitigni valdostani acquisiscono la fama. Nel 1550 Leandro Alberti loda il paesello di Bard per un “soave Moscatello con molti altri buoni vini”. Nella seconda metà dell’800, la posizione e il clima rigido arginarono la diffusione della fillossera nei vitigni della Valle d’Aosta, che però non risparmiò la varietà autoctona dell’antico Muscatel de Saint Denis. Nel 1983 tutta la produzione regionale viene raccolta sotto la comune Denominazione di Origine Bilingue “Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste DOC”, seguita dal nome del vitigno o dalla qualificazione del vino o del territorio, innescando un processo di innovazione che sta portando verso un futuro tutto da scoprire. La DOC presenta sette sotto-denominazioni per una produzione di circa 27.000 di ettolitri all’anno. Vitigni valdostani: il terroir Il territorio coltivato a vite giace quasi interamente nella media valle e si estende sulle pendici pedemontane da Pont S. Martin a Morgex. Estati caldi e inverni freddi ne fanno un clima ideale per preservare la vite dalle muffe e dalla fillossera. Dal punto di vista geologico, la viticoltura è condizionata dalle Alpi con le sue vette altissime e con rocce di natura metamorfica. I suoli sono leggeri e spesso subacidi, mentre nell’alta e media valle sono importanti i depositi dei ghiacciai (morene). In questa tipologia di territorio la forma di allevamento più usata è la “pergola valdostana”, per una superficie vitata di circa 600 ettari. I vigneti più alti d’Europa. Nelle zone più basse (300-500 metri slm) si coltivano principalmente varietà a frutto nero; nelle zone più alte si coltivano varietà a frutto bianco (fino a 1220 metri slm). Sono molti i vitigni valdostani autoctoni: Fumin, Priè Blanc, Petit Rouge, Vien de Nus, Cornalin, Mayolet e Prëmetta. Possiamo trovare anche Nebbiolo (Picoutener), Pinot Nero, Gamay, Dolcetto, Syrah oppure Moscato bianco (Moscato di Chambave), Pinot Grigio, Pinot Bianco, Muller Thurgau, Chardonnay Blanc de Morgex e de La Salle. Il Prié Blanc è il vigneto più alto d’Europa (fino a 1200 metri) grazie alle sue caratteristiche che ne facilitano la coltivazione. Compie il suo ciclo vegetativo in un tempo molto breve, germoglia tardivamente e matura precocemente verso la fine di agosto.
Il Vitigno Mayolet e i suoi vini
Il vitigno Mayolet è riportato in Valle d’Aosta fin dalla fine del ‘700, per cui con buone ragioni si può ritenerlo un autentico autoctono valdostano. Il Mayolet occupa un areale di coltivazione piuttosto ampio, che si estende da Saint-Vincent ad Avise, sulla destra e sulla sinistra della Dora Baltea, e viene coltivato su pendii fino alla considerevole altitudine di 800 metri sul mare, assieme ad altre varietà della zona. E’ il più precoce degli autoctoni valdostani. Non si riportano vigneti di Mayolet in coltura specializzata ma le sue uve concorrono alla produzione di alcuni vini rossi della Valle d’Aosta DOC, per la cui composizione ne viene impiegato fino all’85%, con l’aggiunta del 15% di altre uve a bacca nera autorizzate per la Valle d’Aosta. E’ un vino dalle caratteristiche organolettiche peculiari, che necessita di un periodo di affinamento fino a cinque-sei mesi.
Il vino ottenuto dal vitigno Mayolet ha colore rosso rubino che tende leggermente al granato e un profumo molto fine e delicato. Al palato il Mayolet risulta alquanto morbido con un tipico retrogusto amarognolo. Si abbina a pietanze molto semplici e non eccessivamente elaborate, quali carni bianche, formaggi più o meno maturi e salumi caratteristici della zona valdostana.
Il Vitigno Vuillermin e i suoi vini
Il vitigno Vuillermin, dopo avere rischiato l’estinzione, viene attualmente coltivato in maniera sporadica e quasi esclusivamente nei Comuni di Chambave e Chatillon in provincia di Aosta. Questo antico vitigno autoctono a bacca nera era una volta chiamato Eperon o Spron, nomi ormai scomparsi. Il Vuillermin sembra essere imparentato geneticamente con il Fumin, anche se secondo recenti studi deriva lontanamente dal Petit rouge e ha qualche vicinanza anche con il Cornalin. Dal punto di vista ampelografico, il Vuillermin ha foglia medio-grande, cuneiforme, tri o pentalobata. Il grappolo è medio-piccolo, piramidale, alato, mediamente compatto, con acini medio-piccoli, sferici, dalla buccia consistente, pruinosa, di colore blu opaco. Dalla vinificazione delle uve Vuillermin in purezza si ottiene un vino di colore rosso violaceo carico. Al naso è vinoso ed intenso, al palato ha gusto pieno, buona tannicità ed ottima struttura.
Il Vitigno Neyret e i suoi vini
Il vitigno Neyret è caratteristico della Valle d’Aosta. Poco diffuso, con una produzione quantitativamente insignificante sia ai giorni nostri che nel passato, le pochissime citazioni presenti sul Neyret lo fanno provenire dalla vicina Francia e o dalla Svizzera, ma il suo arrivo in Valle d’Aosta è piuttosto da attribuire agli scambi commerciali con il Canavese o con il resto del Piemonte. Alcuni test eseguiti sul DNA lo fanno appartenere gruppo dei Neretti piemontesi (come il Neretto del pinerolese o lo Chatus). Il nome Neyret deriva dal colore blu nero dei suoi acini e dalla sua conseguente capacità di dare vita a un vino molto ricco di colore. I pochi filari di Neyret presenti in Valle d’Aosta si possono scovare nella zona compresa tra Arnad e Montjovet, in particolare sulla sinistra orografica della Dora, ad altitudini non molto elevate.
La Zona di Coltivazione
Il Neyret è coltivato principalmente nella Valle d’Aosta, una delle regioni più piccole e montuose d’Italia. Qui, le viti crescono su terrazzamenti che si arrampicano sui pendii delle montagne, a un’altitudine compresa tra i 600 e i 1000 metri sul livello del mare. Le condizioni climatiche sono particolarmente difficili, con inverni rigidi ed estati brevi, ma caratterizzate da una buona esposizione solare e da notevoli escursioni termiche. Questi fattori permettono al Neyret di sviluppare aromi intensi e una buona acidità, elementi distintivi dei vini di montagna.
I terreni della Valle d’Aosta sono di origine morenica e alluvionale, con una buona percentuale di sabbia e ghiaia che assicurano un eccellente drenaggio. Questi suoli poveri ma ben aerati contribuiscono a limitare la produttività della vite, concentrando la qualità nei pochi grappoli che vengono prodotti.
Caratteristiche Ampelografiche e Agronomiche
Ampelograficamente, il Neyret si presenta con foglie di medie dimensioni, pentagonali e trilobate, dal colore verde intenso. I grappoli sono di piccole dimensioni, con una forma cilindrica e abbastanza compatti. Gli acini sono piccoli, di forma rotonda e di colore blu-nero, con una buccia piuttosto spessa e ricca di antociani.
Dal punto di vista agronomico, il Neyret è un vitigno rustico e resistente, capace di adattarsi bene alle difficili condizioni climatiche della montagna. Tuttavia, è sensibile a particolari malattie della vite come l’oidio e richiede una gestione attenta nel vigneto. La sua resa è generalmente bassa, ma questo si traduce in una qualità superiore delle uve, che sviluppano una buona concentrazione di zuccheri e aromi. La vendemmia avviene tardivamente, spesso tra fine settembre e inizio ottobre, quando le uve hanno raggiunto una maturazione ottimale.
Caratteristiche Organolettiche dei Vini
I vini ottenuti dal Neyret sono rappresentativi della viticoltura di montagna, con un profilo aromatico fresco e vivace. Dal punto di vista visivo, i vini di Neyret presentano un colore rosso rubino chiaro, con riflessi violacei nelle versioni più giovani.
Al naso, i vini offrono un bouquet fragrante, con note di frutti di bosco come ribes e mora, accompagnate da sentori floreali di viola e rosa, e da un leggero accenno speziato, tipico delle varietà alpine. A seconda delle tecniche di vinificazione, possono emergere anche note di erbe aromatiche e sottobosco, che aggiungono complessità al profilo aromatico.
Al palato, i vini di Neyret sono caratterizzati da una buona acidità, che conferisce freschezza e bevibilità, con tannini morbidi e ben integrati. La struttura è leggera ma equilibrata, rendendo questi vini piacevoli da bere sia in gioventù che dopo un breve periodo di affinamento. Il finale è asciutto, con un retrogusto delicatamente fruttato e leggermente speziato.
Il Vitigno Nebbiolo e i suoi vini
Il vitigno Nebbiolo è l’autoctono piemontese per antonomasia. Il suo nome potrebbe derivare da “nebbia“, secondo alcuni perchè gli acini sono ricoperti da abbondante pruina, mentre per altri per il fatto che è un’uva che viene vendemmiata in ottobre avanzato, quando i vigneti sono avvolti dalle nebbie mattutine. Il Nebbiolo è sicuramente il vitigno a bacca nera più pregiato e difficile tra gli italiani.
I Cloni del Nebbiolo
Sono stati identificati tre cloni principali del vitigno Nebbiolo, il Lampia, il Michet e il Rosé. Il Michet dà basse rese ed esprime aromi e gusto particolarmente intensi, mentre il Rosé produce vini dal colore molto scarico e sta via via scomparendo. La maggior parte dei vignaioli preferisce comunque lavorare su una miscela delle tre uve, proprio per dare al prodotto finale una maggior complessità.
Le zone di coltivazione del Nebbiolo
L’eccellenza della produzione del Nebbiolo è concentrata nelle Langhe e più precisamente nelle zone del Barolo e del Barbaresco (Piemonte) e in Valtellina (Lombardia). Fuori da queste aree di elezione le uve del Nebbiolo non hanno più quello spessore, quella forza e quella “nobiltà” che lo rendono unico al mondo.Nelle aree piemontesi di Boca, Bramaterra, Fara, Gattinara, Ghemme, Lessona e Sizzano è chiamato Spanna, mentre in Valtellina prende il nome di Chiavennasca. A Ghemme e Gattinara, due minuscole oasi tagliate dal fiume Sesia, nel nord del Piemonte, tra Vercelli e Novara, il Nebbiolo lo si trova in blend con la Vespolina, per dare piccole produzioni (appena 100 ettari per il Gattinara) non prive di piacevoli sorprese. Nella zona della DOC Boca, grazie a suoli rocciosi e all’escursione termica, si scoprono finezza di bouquet e sfumature minerali, piuttosto che la concentrazione dei tannini. A Carema, un comune al confine con la Valle d’Aosta, le difficoltà che impone la coltivazione della vite in altitudine hanno spinto molti ad abbandonare i vigneti, ma il Nebbiolo che se ne ottiene è estremamente intenso, con tannini evoluti, note di ciliegia sotto spirito, pepe e cacao, petali di rosa e le classiche note terrose di montagna. Un simile scenario di ripidi terrazzamenti intagliati tra le montagne, si ha in Valtellina, l’unico vero baluardo del Nebbiolo al di fuori del Piemonte, che qui viene chiamato Chiavennasca. Le versioni locali del Valtellina superiore DOCG includono il Sassella, dai tratti molto fini, il Grumello, fresco e con note minerali, l’Inferno, forse il più robusto e scorbutico, e infine il Valgella, più leggero e floreale. Lo Sforzato di Valtellina, detto Sfursat, è un vino prodotto da grappoli raccolti e poi fatti appassire per tre mesi, a cui segue una lunga vinificazione per estrarre tutto il possibile dalle bucce di Nebbiolo e almeno 12 mesi di affinamento in botte. Il Nebbiolo è molto usato anche in Valle d’Aosta, dove è chiamato Picoutener (Picotendro).
Il Vitigno Freisa e i suoi vini
La Freisa è un vitigno a bacca nera autoctono del Piemonte, diffuso nel Monferrato Astigiano e Casalese, fino alla Langa Cuneese e dalle colline Torinesi alle colline del Saluzzese, del Pinerolese, del Canavese e del Novarese. È un vitigno rustico, ideale in quest’area di scarse precipitazioni estive. Il Freisa ha una storia molto antica, infatti le prime testimonianze scritte risalgono al cinquecento quando un vino molto pregiato con il nome di Fresearum veniva inserito in alcuni tariffari della dogana piemontese del comune di Pancalieri, nell’attuale provincia di Torino. Il Di Rovasenda lo inserì tra i più diffusi vitigni del Piemonte nel suo Album ampelografico. Sono documentate almeno due varietà di Freisa, la Freisa Piccola, meno produttiva e più adatta alle zone collinari, e la Freisa Grossa, più produttiva ma qualitativamente meno pregiata.
Dal punto di vista ampelografico il Freisa presenta grappoli lunghi di forma cilindrica, poco alati, quasi spargoli. Glia acini sono tendenzialmente ovali con dimensioni medie con molta presenza di pruina su bucce fini ma molto coriacee, di colore nero tendente al blu. La Freisa è un vitigno vigoroso, ed ha rese medio alte specialmente nel sottotipo Grosso. Ha maturazione medio-tardiva e viene allevato a controspalliera e il Guyot, con potature espanse e lunghe. La Freisa resiste bene alle malattie e alle muffe anche se manifesta una certa sensibilità all’oidio. I terreni del Piemonte a struttura argillosa e marnosa sono un ottimo luogo per la Freisa, che è utilizzata sia in purezza che nei tagli in tutta la regione. La Freisa dà ai vini colore e buona concentrazione tannica e profumi fruttati. La componente acida e la struttura gli consentono invecchiamenti di medio termine. Al palato può essere secco o amabile e può presentarsi in versione leggermente frizzante. Da giovane è un vino fresco, dotato di vivacità e brillantezza, mentre con il tempo assume toni più maturi, con i frutti in confettura e qualche accenno terziario. Nella versione dolce è un ottimo abbinamento per la pasticceria secca o cremosa, mentre quella secca si abbina con i salumi, le carni rosse non elaborate e alcuni formaggi stagionati, ma si può anche con primi piatti al ragù.
Il Vitigno Moscato bianco e i suoi vini
Il vitigno Moscato bianco è un’uva aromatica diffusa in quasi tutta la penisola italica ed una delle più importanti per superficie vitata. Appartiene alla grande famiglia dei Moscati, vitigni aromatici il cui nome deriva da “muscum“, muschio, il cui aroma caratteristico si ritrova nell’uva e che probabilmente corrisponde all’anathelicon moschaton dei Greci o all’uva apiana nell’antica Roma. Corrisponde al vitigno francese Muscat à petit grains laddove il termine francese musquè viene correttamente tradotto come “aromatico”. Il Moscato bianco ha moltissimi sinonimi, per lo più in riferimento ai vini che se ne producono o alle diverse zone di produzione in tutta Italia. I principali sono: Moscadello di Montalicino, Moscato di Canelli, Moscato di Trani, Moscato d’Asti, Moscato di Siracusa, Moscato di Sorso Sennori e Weisser Muskateller in Alto Adige.
In Piemonte il Moscato bianco è di gran lunga il vitigno a bacca bianca più intensamente coltivato e uno dei principali in molti comuni delle province di Cuneo, Asti e Alessandria. È presente, anche se sporadicamente, in molte altre zone viticole piemontesi, comprese le aree montane e pedemontane. Nel resto d’Italia, è conosciuto e utilizzato per la produzione di vini aromatici in Valle d’Aosta, Oltrepò Pavese, Toscana, Puglia, Sicilia e Sardegna. La sua coltura all’estero è diffusa in tutto il mondo vitivinicolo. Il Moscato bianco è un vitigno molto versatile, i cui vini vengono suddivisi in tre grandi categorie: i vini secchi e aromatici, molto freschi e beverini, i vini dolci frizzanti come lo spumante Asti DOCG, oppure le vendemmie tardive e i vini passiti dolci da dessert. I vini del Moscato bianco sono vini molto aromatici, leggeri ed eleganti, dotati di buona freschezza, con note floreali e di agrumi e salvia. Sono che non hanno mai una struttura mastodontica, anzi, si contraddistinguono per la loro leggerezza. Sono vini eleganti, con ottima acidità e una mineralità appena accennata. L’Asti Spumante si contraddistingue per la bevibilità, mentre il Moscato bianco passito di cui una delle massime espressioni è il Moscato di Loazzolo DOC, è un vino totalmente diverso, mieloso, maturo, con una dolcezza che a volte assume tratti viscosi e note marcate di frutta candita e fiori che appassiti.