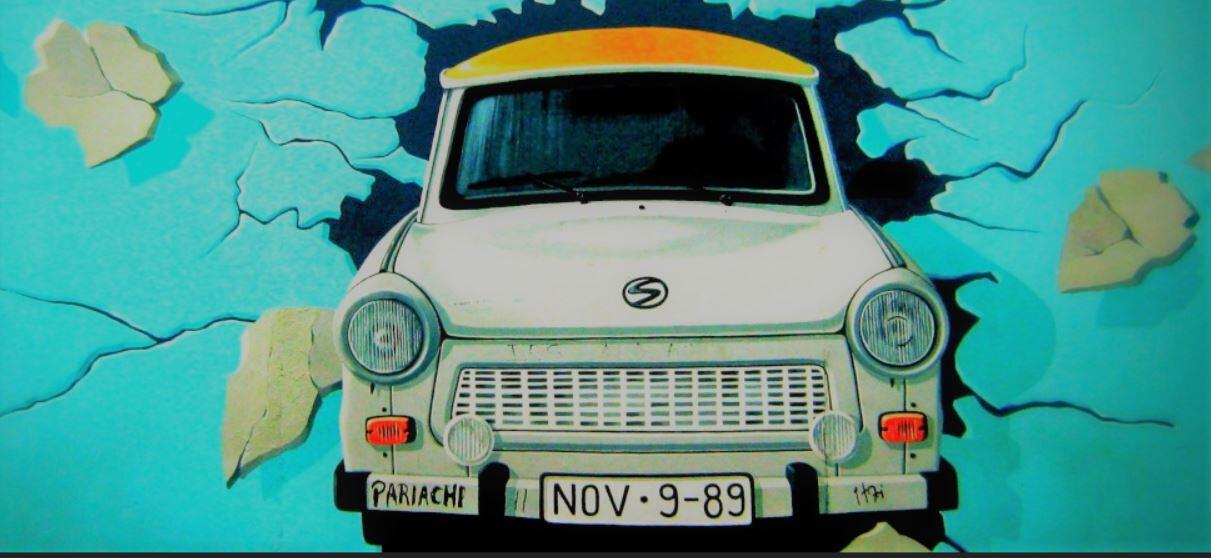Il fenomeno della dipendenza affettiva ha suscitato una crescita di interesse e studi a partire dagli inizi degli anni ’80; la sua conoscenza, a livello della popolazione mondiale, fu dovuta alla prima pubblicazione del libro di Robin Norwood “Donne che Amano troppo” (1985). L’autrice, psicoterapeuta famigliare specializzata nel campo delle dipendenze, definisce il fenomeno della dipendenza affettiva “troppo amore”, descrivendolo come il bisogno, non consapevole, di legarsi a partner incompatibili con i propri sentimenti, non curanti del benessere dell’altro, non disponibili, velatamente o chiaramente rifiutanti, unito all’incapacità di distaccarsene e al pensiero magico di riuscire, tramite l’amore e il sacrificio di sé, a cambiarli e trasformarli nei partner dei propri sogni.
Marazziti e collaboratori (2015) ben riassumono gli elementi comuni riscontrati all’interno della macrocategoria delle dipendenze:
- piacere e sollievo, sensazioni gradevoli ma limitate ai periodi iniziali dell’uso della sostanza o della messa in atto del comportamento, fase denominata “luna di miele”;
- dominanza o idea prevalente riferita alla sostanza o al comportamento, per cui vi è l’impossibilità di resistere all’impulso di assunzione o pratica, vissuta con modalità compulsive;
- craving, sensazione crescente di tensione e desiderio che precede l’assunzione della sostanza o la pratica del comportamento;
- instabilità dell’umore
- tolleranza ossia la progressiva necessità di incrementare la quantità di sostanza o tempo dedicato al comportamento per ottenere l’effetto piacevole, il quale tenderebbe altrimenti ad esaurirsi;
- discontrollo, la progressiva sensazione di perdita di controllo sull’assunzione della sostanza o esecuzione del comportamento;
- astinenza, il profondo disagio fisico e psichico conseguente all’interruzione o alla ridotta assunzione della sostanza o alla riduzione del tempo dedicato alla messa in atto del comportamento;
- conflitto e persistenza, dovuti all’incapacità di porre fine all’assunzione di una sostanza o alla pratica di un comportamento nonostante le evidenti conseguenze sulla vita dell’individuo;
- ricadute, ossia la tendenza a riavvicinarsi alla sostanza o ad attuare il comportamento dopo un periodo di interruzione;
- poliabuso, ossia la tendenza ad assumere più sostanze o praticare più comportamenti e cross-dipendenza, ossia la tendenza a passare da una dipendenza all’altra nell’arco della storia di vita;
- fattori di rischio comuni, quali sensation seeking impulsività , difficoltà nella regolazione emotiva, inadeguato ambiente di sviluppo genitoriale, attaccamento insicuro e presenza di trauma
-
La dipendenza affettiva: definizione e fattori predisponenti
Per quanto riguarda più precisamente la dipendenza affettiva, secondo Giddens sono tre le principali caratteristiche a connotarla come vera e propria forma di dipendenza.
La prima è l’ebbrezza, la sensazione di euforia legata alla vicinanza del partner e alle sue reazioni rispetto ai propri comportamenti. La seconda è la tolleranza o “dose”, ossia il bisogno di aumentare il tempo trascorso in compagnia del partner, riducendo di conseguenza quello dedicato a sé e ai contatti esterni alla coppia. Tale aspetto sarebbe alimentato dall’incapacità di mantenere la presenza interiorizzata rassicurante dell’altro: a causa di ciò, l’assenza della persona di cui si è dipendenti comporterebbe uno stato di disperazione risolvibile solo mediante la presenza concreta dell’altro in quanto il solo pensiero non risulta rassicurante di per se stesso. L’ultima caratteristica è l’incapacità di controllare il proprio comportamento, connessa alla perdita della capacità critica relativa a sé, alla situazione e all’altro: ciò provocherebbe un conseguente senso di vergogna, il quale, in momenti di lucida razionalità, permette di comprendere la portata nociva della propria situazione e del malessere sperimentato ma che, quasi inevitabilmente, viene sostituito da una sensazione di indegnità, la quale porta nuovamente a ricadere nella propria dipendenza affettiva
ricercando “l’abbraccio” dell’altro (Giddens, 1992).
Sulla base delle analogie tra dipendenza affettiva e dipendenza da sostanze, Reynaud e collaboratori (2010) hanno proposto una definizione maggiormente sistematica di tale patologia, unita ad alcuni criteri diagnostici. Essa, viene definita come un modello disadattivo o problematico della relazione d’amore che porta a deterioramento e angoscia clinicamente significativa, come manifestato da tre (o più) dei seguenti criteri (che si verificano in ogni momento, nello stesso periodo di 12 mesi, per i primi cinque criteri):
- esistenza di una sindrome caratterizzata da astinenza in assenza dell’amato;
- significativa sofferenza e bisogno compulsivo dell’altro;
- considerevole quantità di tempo speso su questa relazione (nella realtà o nel pensiero);
- riduzione di importanti attività sociali, professionali o di svago;
- persistente desiderio o sforzi infruttuosi di ridurre o controllare la propria relazione;
- ricerca della relazione, nonostante l’esistenza di problemi creati dalla stessa;
- esistenza di difficoltà di attaccamento come manifestato da ciascuno dei seguenti:
– ripetute relazioni amorose esaltate, senza alcun periodo di attaccamento durevole;
– ripetute relazioni amorose dolorose, caratterizzate da attaccamento insicuro.
La dipendenza affettiva sarebbe, dunque, una modalità patologica di vivere la relazione, in cui la persona dipendente, per non perdere il partner, silenzia i propri bisogni per dare voce solo a quelli dell’altro, considerato unica e sola fonte di gratificazione, anche quando da essa non se ne riceve più alcuna. I dipendenti affettivi sono sostanzialmente innamorati del sentimento d’amore, spesso mai conosciuto intimamente e che quindi non riescono a distinguere da ciò che non lo è. Sono alla costante ricerca di partner guidati dalla convinzione che, in qualche modo, la relazione possa avere poteri magici, salvifici, permetta di superare qualsiasi ostacolo (Peele & Brodsky, 1992), ritenendo che solo assieme a un’altra persona ci si possa sentire completi (Yoder, 1990). Il dipendente affettivo, a causa di una bassissima autostima di base, è terrorizzato dall’abbandono del partner e vive in un generico stato di allerta manifestato con gelosia, possessività, comportamenti di controllo, opposizione al cambiamento e bisogno di una relazione vissuta in simbiosi. Nelle relazioni, spesso, sperimenta rabbia, rancore, sensi di colpa e un profondo senso di inadeguatezza dato dalla convinzione di essere inferiore al partner, del cui amore non è meritevole.
Dipendendo dall’altro per potersi dare esistenza, chi soffre di dipendenza affettiva per evitare l’abbandono e quindi evitare di ricevere la conferma del poco valore di cui si crede portatore, non soltanto rinnega i propri bisogni sottomettendoli ai bisogni dell’altro, ma accetta e tollera qualsiasi tipo di comportamento emesso dal partner, nella speranza di mantenere la vicinanza. Ne deriva che, di fronte a maltrattamenti fisici, verbali o psicologici, nella fasulla convinzione di mantenere il controllo sulla relazione e poter dunque continuare a praticare la propria dipendenza affettiva, il soggetto si assume la responsabilità dei comportamenti dell’altro (ad es. giustificando i tradimenti come causa della propria incapacità di soddisfarlo). Infine, non solo vi è la difficoltà ad interrompere la relazione dopo periodi prolungati di malessere, per quanto vi è la tendenza a ricadere nella stessa relazione dopo mesi o a sostituirla con una relazione simile instaurata assieme ad altri partner.